In ognuno di noi, anche in quelli che fortemente la ripudiano, sopravvive o prospera il fascino della violenza. Più o meno controllata nei toni di un dibattito pubblico, evocata e mitizzata nelle forme artistiche, imbrigliata nei regolamenti degli sport di contatto: dal punto di vista del fruitore dello spettacolo violento, al riparo nella sua safe zone, la violenza è in qualche modo tollerata perché lontana, apprezzata perché normata. Il pugilato è forse l’incarnazione di questo sentimento e Gladiatori di Antonio Franchini ne è il racconto: storie di pugili e combattenti, che raccontano i round del loro riscatto sociale, attraverso i guantoni e il sudore dell’allenamento.

Quello di Antonio Franchini e Piero Pompili, autore delle fotografie presenti nel libro, è un pellegrinaggio nelle palestre della penisola: li immagino varcare i confini delle periferie, entrare in quei luoghi di fatica, e cercare un’esistenza da raccontare personificata dall’atleta dimenticato in un angolo. Una sacralità immotivata e stucchevole si potrebbe dire, eppure da molti degli elementi di Gladiatori traspare: il gong che chiama i fedeli a raccolta attorno al ring-altare, presieduto da un arbitro-sacerdote a cui tocca “non solo dire preghiere ma invocare demoni, frugare interiora” degli atleti sacrificali. Una sensazione che viaggia lungo tutta la narrazione, un continuum senza pause o intervalli di capitolo.

La narrazione del riscatto sociale dell’atleta è sì verità nel mondo del pugilato ma, visto il valore altamente educativo del tema, troppo spesso diventa cliché iperrappresentato. Ciò che più mi ha colpito nelle storie di questi lottatori è il loro rapporto con la violenza, con l’ingaggio fisico. Qualcosa di simile a un uroboro, il serpente senza inizio e senza fine: un uroboro della violenza. Nelle discipline di combattimento si rifiuta, si respinge violentemente l’avversario; si è consapevoli della fatalità dei colpi dati e ricevuti. Al contempo, ciò che potenzialmente uccide ha un potere magnetico, una botta adrenalinica di cui non si può fare a meno. “Non so se questo mi aiuterà a morire, so che mi aiuta a vivere”: due aspetti che inspiegabilmente agli occhi di chi non pratica queste discipline, convivono e alimentano l’uno l’altro.

Verso la conclusione del libro viene data particolare attenzione al mondo del wrestling: disprezzato dai professionisti del pugilato perchè finto, amato da chi, come il sottoscritto da bambino, credeva alle gesta di Big Show, Undertaker e Rey Mysterio come a Babbo Natale. Sono storie immaginarie, scritte a tavolino, a cui il pubblico ha deciso deliberatamente di credere: una sorta di patto col lettore-spettatore viene sottoscritto, tra il wrestler e il pubblico dell’arena. Gladiatori si spinge oltre sul giudizio “positivo” della disciplina: proprio come accadrebbe con un’opera d’invenzione, ad esempio con un romanzo, alle volte il wrestling è più vero e autentico della realtà stessa. Non sempre i buoni vincono, non sempre sono ligi al regolamento: “se vado a vedere Rambo so che Rambo vincerà. Se vado a vedere il wrestling può succedere che il mio campione esca sconfitto”. In questa mancanza di rigida dualità, il wrestling è più vicino alle vite degli spettatori, alle fisiologiche sfumature di comportamento.

Antonio Franchini ha messo in versi lo sport; Piero Pompili ha dipinto con la luce i volti e i corpi dei protagonisti di queste storie di lotta. Il risultato è Gladiatori, un fil rouge che unisce antichi Romani, pugili del Novecento e star dell’MMA nel segno della bellezza del combattimento, tanto nei gesti atletici quanto nel significato profondo che questa porta con sé come metafora di vita.









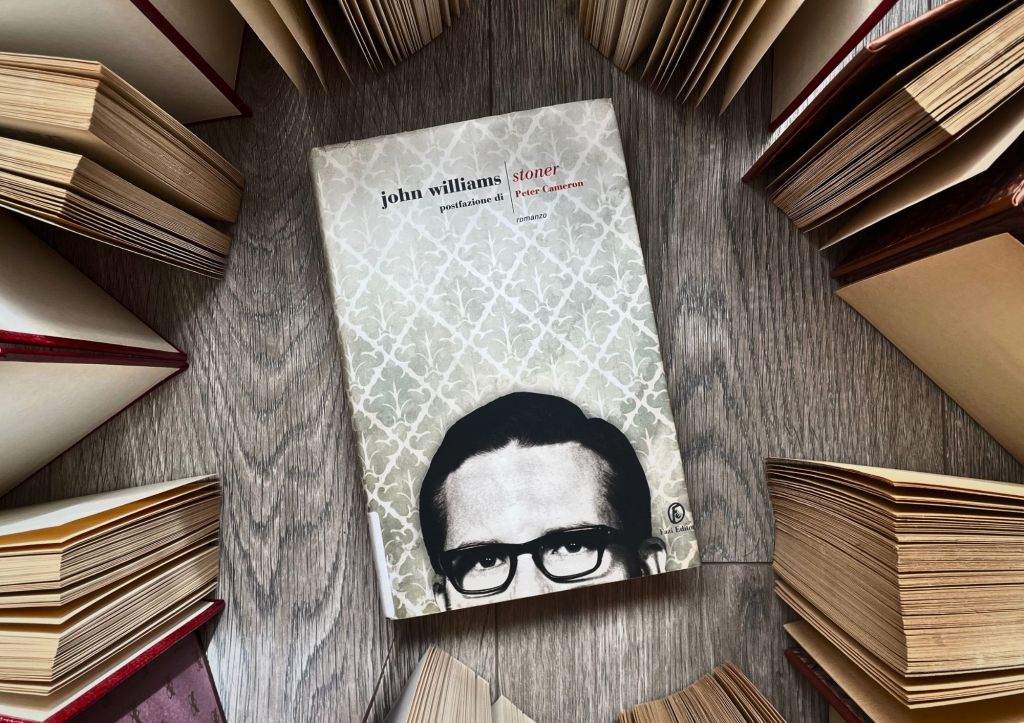
Lascia un commento